L’immigrazione in Argentina raccontata da Gastón Gori, scrittore di origini italiane.
 Avvocato e scrittore, Gastón Gori (pseudonimo di Pedro Marangoni) nasce a Esperanza (ex colonia di immigranti europei) nel 1915. È nipote di immigranti friulani che si stanziarono ad Esperanza negli anni ‘70 del XIX secolo. Gori, però, non è molto conosciuto al di fuori del contesto argentino. Eppure, è un elemento molto importante nello studio dell’immigrazione europea in Argentina. I suoi scritti spaziano da studi scientifici e storici a racconti fittizi, ma tutti a volti ad analizzare l’immigrazione in uno studio che tende alla ricerca della verità. Gori non ha vissuto direttamente il processo d’immigrazione, ma è legittimato a parlarne in quanto è cresciuto nella colonia di Esperanza, i nonni erano italiani ed è stato uno dei primi studiosi che ha deciso di documentarsi e studiare avanti poterne parlare. Inoltre, grazie agli studi da avvocato, per Gori è fattibile analizzare come la società oligarchica argentina abbia cercato di organizzare la colonizzazione europea nella pampa, l’immigrazione urbana (le due si dividono in immigrazione organizzata e spontanea) e la distribuzione della terra. L’oligarchia, per aiutare l’Argentina a crescere economicamente (come stabilito dalla Costituzione argentina firmata a Santa Fe nel 1853), offre le terre fertili agli europei che, spinti dalla necessità di sopravvivenza, prendono al volo l’occasione. L’immigrante è speranzoso di poter velocemente esercitare il ruolo di padrone del pezzo di terra assegnatoli, ma, molto spesso, inizia la sua avventura già indebitato: riceve animali, materiale, attrezzi, ma in cambio deve pagare con denaro o con un terzo della cosecha. Chi riesce a pagare il debito può diventare a sua volta proprietario del suo campo. Un esempio di successo è la colonia di Esperanza, da Gori nominata come “madre de colonias” (Esperanza, madre de colonias, 1969), la prima ad aver ottenuto ottimi risultati; mentre un caso particolare che trionfa e di cui Gori racconta, è il personaggio fittizio di El desierto tiene dueño (1958), Ernesto Bourdin. Dalla Svizzera, con la famiglia si stabilisce nella pampa, precisamente nella colonia di San Carlos, fondata dall’imprenditore Charles Beck-Bernard. Inizialmente, lavorare la terra è un’operazione ostica: la pampa è deserta, infinita, piena di segreti, lavorarla è difficile e diventa metafora della difficoltà dell’immigrato europeo nell’adattarsi a questa nuova realtà L’umore di Bourdin peggiora con i fallimenti finchè riesce con la famiglia a pagare il debito e diventare padrone del suo campo.
Avvocato e scrittore, Gastón Gori (pseudonimo di Pedro Marangoni) nasce a Esperanza (ex colonia di immigranti europei) nel 1915. È nipote di immigranti friulani che si stanziarono ad Esperanza negli anni ‘70 del XIX secolo. Gori, però, non è molto conosciuto al di fuori del contesto argentino. Eppure, è un elemento molto importante nello studio dell’immigrazione europea in Argentina. I suoi scritti spaziano da studi scientifici e storici a racconti fittizi, ma tutti a volti ad analizzare l’immigrazione in uno studio che tende alla ricerca della verità. Gori non ha vissuto direttamente il processo d’immigrazione, ma è legittimato a parlarne in quanto è cresciuto nella colonia di Esperanza, i nonni erano italiani ed è stato uno dei primi studiosi che ha deciso di documentarsi e studiare avanti poterne parlare. Inoltre, grazie agli studi da avvocato, per Gori è fattibile analizzare come la società oligarchica argentina abbia cercato di organizzare la colonizzazione europea nella pampa, l’immigrazione urbana (le due si dividono in immigrazione organizzata e spontanea) e la distribuzione della terra. L’oligarchia, per aiutare l’Argentina a crescere economicamente (come stabilito dalla Costituzione argentina firmata a Santa Fe nel 1853), offre le terre fertili agli europei che, spinti dalla necessità di sopravvivenza, prendono al volo l’occasione. L’immigrante è speranzoso di poter velocemente esercitare il ruolo di padrone del pezzo di terra assegnatoli, ma, molto spesso, inizia la sua avventura già indebitato: riceve animali, materiale, attrezzi, ma in cambio deve pagare con denaro o con un terzo della cosecha. Chi riesce a pagare il debito può diventare a sua volta proprietario del suo campo. Un esempio di successo è la colonia di Esperanza, da Gori nominata come “madre de colonias” (Esperanza, madre de colonias, 1969), la prima ad aver ottenuto ottimi risultati; mentre un caso particolare che trionfa e di cui Gori racconta, è il personaggio fittizio di El desierto tiene dueño (1958), Ernesto Bourdin. Dalla Svizzera, con la famiglia si stabilisce nella pampa, precisamente nella colonia di San Carlos, fondata dall’imprenditore Charles Beck-Bernard. Inizialmente, lavorare la terra è un’operazione ostica: la pampa è deserta, infinita, piena di segreti, lavorarla è difficile e diventa metafora della difficoltà dell’immigrato europeo nell’adattarsi a questa nuova realtà L’umore di Bourdin peggiora con i fallimenti finchè riesce con la famiglia a pagare il debito e diventare padrone del suo campo.
La ricerca della fortuna spinge un numero spropositato di europei ad emigrare in Argentina con la speranza di poter lavorare le sue terre. Attorno al 1870 l’immigrazione diventa incontrollata e i contadini non ricevono più contratti regolari. Questo favorisce abusi, sfruttamento, favoritismi, la nascita del latifondo e come conseguenza, l’impoverimento della psiche dell’immigrato costretto a volte a fare un lavoro pesante e monotono, sotto un padrone e senza nessuna prospettiva di miglioramento. Molti si trasferiscono nelle città per tentare una sorte migliore, ma nemmeno l’immigrazione urbana sfugge alle difficoltà. È probabilmente il caso dell’italiano Nicola di cui Gori parla in El ultimo reparto, racconto pubblicato in El camino de las nutrias. Otros cuentos del 1955. Nicola per 20 anni ad Esperanza lavora e trasporta il ghiaccio durante l’estate. Vive in una stanza di legno, con odore nauseante e sporca, ma che non può modificare perché proprietà del padrone. A causa delle condizioni poco favorevoli e del calore torrido, Nicola ha un volto invecchiato dal lavoro ed è stremato. Nella sua ultima giornata, gli appare la visione di una donna che lo accompagna fino alla sua stanza dove muore. Forse l’ultima e unica possibilità di riscattare la propria dignità, consumato dalla stanchezza fisica e psicologica e dalla consapevolezza di non essere padrone nemmeno di sé stesso.
Sempre nella stessa raccolta, si può leggere la storia di Nacho: panettiere in Italia e poi ad Esperanza, a Santa Fe e a Cavour. Questo italiano ha un carattere turbolento: è schiavo dell’alcol e, gelosissimo della moglie, la abbandona quando resta incinta. A Cavour è ben noto per il suo naso e per essere un ubriacone. Tutti lo conoscono, ma al momento della sua morte tutti ne spettegolano rivelando falsa solidarietà e malignità. Muore da solo in condizione pietose.
Antonini invece (La muerte de Antonini, 1956) migliora la sua condizione economica. Il padre con l’amico emigrano dal Veneto per stabilirsi in una città del litorale ricca di cosechas, trigos e maíz. Alternano il lavoro de jornalero con quello della trilla. Sono jornaleros agrícolas nella pampa, ma marginali senza terra. Alla morte della moglie e dei fratelli a causa del vaiolo, il papà torna in Italia lasciando Antonini alla famiglia dell’amico il cui figlio Dalmacio racconta le vicende del “fratello” durante il funerale di quest’ultimo. È l’unico che dimostra un po’ di pietà per Antonini. Il piccolo cresce in silenzio, ma la sua indole avara e tirchia si accentua sempre di più. Imbroglia, racconta menzogne e manipola le persone per accaparrarsi le proprietà altrui. Diventa proprietario di alcuni appartamenti che affitta, ma tratta con egoismo gli inquilini, in quanto li vede come causa di una sua possibile rovina economica. Sposa la figlia di un proprietario di terre, la umilia e la controlla. Incapace di far fronte ai cambiamenti economici e politici a causa della sua indole avara, Antonini muore solo e odiato da tutti. Se da un lato, Antonini si è arricchito economicamente, dall’altro si è ridotto a fare lo stesso gioco dell’oligarchia e si è corrotto moralmente. Si potrebbe pensare che Dalmacio e Antonini siano le due facce della stessa medaglia: il primo onesto, il secondo corrotto. Forse Antonini rapresenta quella parte di immigrati che, nel tentativo di rivendicare un’ascesa sociale, perde la propria integrità morale. La sua morte è fisica, ma simboleggia anche la perdita dell’onestà sociale. La sua condizione ricorda il giudizio negativo sviluppatosi dal governo argentino quando il numero di immigrati stava diventando troppo elevato e venivano incolpati di corrompere la società argentina. Ma, si sa, non tutti gli immigrati sono stati mala gente, anche se non tutti sono stati brava gente. Nicola e Dalmacio sembrano essere l’esempio di immigrato onesto e semplice. Nacho e Antonini, invece, sono la parte negativa della società: il primo corrotto dall’alcool, il secondo corrotto dal denaro.
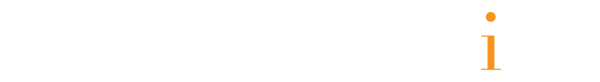
 Sono state recentemente caricate delle foto dei nostri emigranti bellunesi e veneti che hanno scelto il Brasile come paese di destinazione e di speranza. Immagini che ritraggono i nostri conterranei tra l’800 e il ‘900: delle vere e proprie testimonianze che raccontano storie, tutte diverse fra loro, ma per questo uniche e fondamentali per conoscere la nostra storia come emigrati, ma anche come immigrati.
Sono state recentemente caricate delle foto dei nostri emigranti bellunesi e veneti che hanno scelto il Brasile come paese di destinazione e di speranza. Immagini che ritraggono i nostri conterranei tra l’800 e il ‘900: delle vere e proprie testimonianze che raccontano storie, tutte diverse fra loro, ma per questo uniche e fondamentali per conoscere la nostra storia come emigrati, ma anche come immigrati. Le storie di Mario
Le storie di Mario