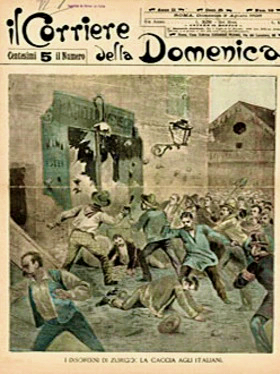Mattmark, 30 agosto 1965
«Avevo una macchina, un camioncino, e andavo a prendere i pezzi. Stavamo andando nella mensa là vicino, a prenderci una birra. Poi ho detto: “Io resto qui, perché se viene il capo, mi chiama, devo andare”. Infatti è arrivato e mi ha chiamato. Allora ho fatto trecento metri giù e… è venuto giù tutto, e gli altri sono rimasti sotto. Il ghiaccio ha proprio spazzato via tutto, una forza tremenda».
(Giancarlo Maggioni)
«La mia officina è andata sotto a dieci, quindici metri di ghiaccio. Quel giorno dovevo prendere il posto di uno, noi lo chiamavano “bocia”, ma io non l’ho mai visto. Era un ragazzo che doveva andare militare perché aveva diciannove, vent’anni, più giovane di me. Io appena tornato dovevo prendere il suo posto. Fatalità, lui aveva il turno di notte, e era di lunedì. Quel giorno, quando è venuto giù il ghiacciaio, lui aveva il turno di notte e io, naturalmente, prendendo il suo posto, dovevo lavorare di notte. Ero giù in cantina, avevo appena finito di mangiare e dovevo salire. Forse mi salvavo lo stesso, chi lo sa, però la mia officina era sotto dieci metri di ghiaccio. Per fortuna di questo“bocia” sono ancora qua che chiacchiero».
(Giancarlo Moretti)
«Erano quasi le sei e con l’escavatore mi sono girato, per vedere se arrivavano ancora camion. All’improvviso ho visto questa cosa, ho fatto un salto in avanti e in un attimo… scommetto che quando ho toccato terra era già passato tutto. E con la coda dell’occhio, come ho fatto il salto, ho visto delle baracche sotto, una decina di tavole che sono saltate in aria, e poi tutto coperto. Il ghiaccio si è fermato a dieci metri di distanza dall’escavatore, proprio come un muro. E il giorno dopo volevano che si andasse a lavorare, ma io non sono andato, “basta”, ho detto».
(Sigfrido Casaril)
«Il giorno dell’incidente, l’amico Silvano mi consegna un pezzo da portare su. Arrivo su e i miei amici erano là in cantina, andavano a bere la birra. Io ero in officina a chiacchierare con un altro mio amico e in quel mentre arriva Acquis Giancarlo. Mi prende per la tuta e mi dice: “Vieni a bere la birra”, insistendo proprio forte. “No, no” dico, “vado giù perché altrimenti dopo il capo mi può anche sgridare”. In quel tempo che mi sono distaccato da questo Acquis, arriva la corriera, sono salito a bordo, una fortuna, e sono tornato giù. Scendendo non si poteva sapere quello che era successo. Arrivo giù e Silvano mi fa: “Cos’è successo lassù?” “Niente”, dico, “tutto a posto”. Nel mentre, veniamo fuori dall’officina, guardiamo su per la gola, là dove c’era la diga, il cantiere: una montagna di ghiaccio, una montagna. Allora siamo corsi subito su. Se, per caso, la corriera passa via, non ho niente con cui scendere e resto là. E a quest’ora ero già finito».
(Gino Da Sois)
Destino, fortuna, casualità. Ci sono molti modi per vedere la questione. Fatto sta che quel giorno qualcuno si è salvato, mentre altri sono morti. Quel giorno è il 30 agosto del 1965, un lunedì. Un lunedì come tanti altri a circa 2.200 metri di quota, in una località del Canton Vallese (Svizzera) chiamata Mattmark. Qui, era in costruzione la diga in terra più grande d’Europa.
Il cantiere brulicava di persone provenienti da diversi Paesi, soprattutto italiani. Ogni cosa sembrava procedere come sempre, almeno fino alle 17:15, quando in pochi istanti tutto cambiò. E qui è necessaria una breve premessa: una parte delle officine e degli alloggi dei lavoratori era posizionata sotto la lingua di un immenso ghiacciaio, l’Allalin, che ogni tanto aveva lanciato qualche segnale. Avvertimenti a cui, a quanto pare, non era stato dato peso.
Fino a che, proprio quel 30 agosto, il ghiacciaio si mise in moto: un blocco di circa due milioni di metri cubi di materiale si staccò e cominciò una letale discesa che travolse tutto ciò che incontrò sulla propria strada, persone comprese.
In ottantotto rimasero sepolti sotto un manto bianco e gelido. Erano “gli altri”, quelli per i quali il destino, la fortuna o il caso avevano girato diversamente. Cinquantasei erano emigrati italiani. Diciassette arrivavano dalla provincia di Belluno: Fiorenzo Ciotti, Pietro Lesana e Enzo Tabacchi di Pieve di Cadore; Giovanni Baracco, Leo Coffen, Igino Fedon, Ilio Pinazza e Rubelio Pinazza di Domegge; Arrigo De Michiel di Lorenzago; Silvio Da Rin di Vigo di Cadore; Celestino Da Rech, Giovanni Zasio e Mario Fabbiane di Sedico; Giancarlo Acquis di Belluno; Aldo Casal di Sospirolo; Lino D’Ambros di Seren del Grappa; Virginio Dal Borgo di Pieve d’Alpago.
Un dramma che rimase senza colpevoli.
(continua)