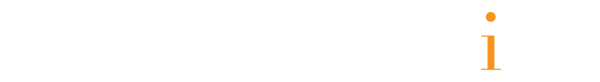Due fradei
L’éra un giorno belissìmo del mese de maio, quando nel orlo del porto de Genova, ntea distante Italia, due fradei de sangue veneto nele vene, i ga visto par la prima volta la grandessa del mar. Umberto e Amedeo Lisot zera el so nome, due bei tosati, co òcii de color blu, cavei negri e anima pura.
Nte che l’giorno, la belessa del mar ghe tirea adosso na mucia de amirassion, anca insieme sufiea n’arieta fresca co la densità che acaressa so pel, accompagnata del mormòlio sonolento dele onde. L’éera un momento magico, co’ l sol a tramonto nel orisonte e drio portar nel cuor la sensassion che l’mondo zera anza gradevol e belo.

Trascorea el remoto ano de 1882 e una stimana avanti i gaveva partiso insieme dei genitori de so paeselo de nassità, ai piè dele “Dolomite” ntea montagneria dei Alpi, provìinsia de Belluno, nel paese Veneto, andove ga i fiori più bei del mondo. Dopo de na stimana nel porto, el signore Giosué, so pupà, ga dito: «Ndemo tossi, l’é ora d’imbarcar nel bastimento, par andare via a lontan a cercare un altro mondo».
… infrontando el grando oceano par rivar a so destin, un stragrando paese, che i Signori d’Italia disea che gaveva de tuto par tuti…
Alora nel momento dela partensa, co destin a la Mèrica, nel s-ciantin che i fassoleti bianchi sgorleva al vent nte un saludo de Adio definitivo, i ga sentisto che i ghe cavea de rento del cuor la Patria Italia. Viniti sinque giorni de viaio, vinti sinque note de paura, infrontando el grando oceano par rivar a so destin, un stragrando paese, che i Signori d’Italia disea che gaveva de tuto par tuti: dolci ornati co l’sùchero briliante, late e gasose par i bambini, vin bonìssimo, pan e salame par i più vècii, la cucagna par tutiquanti.
… i genitori i ga visto che i se gaveva assà imbroiar par la ilusion de brute busie…
Quando i ga riva ntel novo paese, località de “Capão dos Bugres”, che adesso ze la cità de Cassias del Sud, nela Provìnsia de San Piero, i genitori i ga visto che i se gaveva assà imbroiar par la ilusion de brute busie, parvia che no i gi mea trova dolci ornati col sùchero briliante, late e gasose par i bambini, e gnanca vin bonìssimo, pa e salame, i ga trovà solamente la natura e le bèstie de ferossità, alora ntei primi tempi i gaveva el sentimento de ritornar casa al paese veneto, però questo zra impossìbile.
Cossì ga transcoresto la infasnsia e gioventù dei due fradeleti, infrontando la inclemensa dela natura e le bèstie de ferossità, tutavia sempre laorando del s-ciarir al s-curir del dì, co l’pensiero che l’sentido dela so vita zera la fameia, el laoro e la credensa in Dio, inesieme de un sentimento de rispeto al paese che gaveva acoiesto so gente rento del cuor, cossì in pochi ani i gaveva de tuto.
Ademar Lizot
(storia giunta all’Abm grazie a Umberto Lisot e Ester Casagrande)