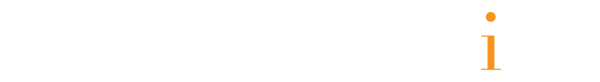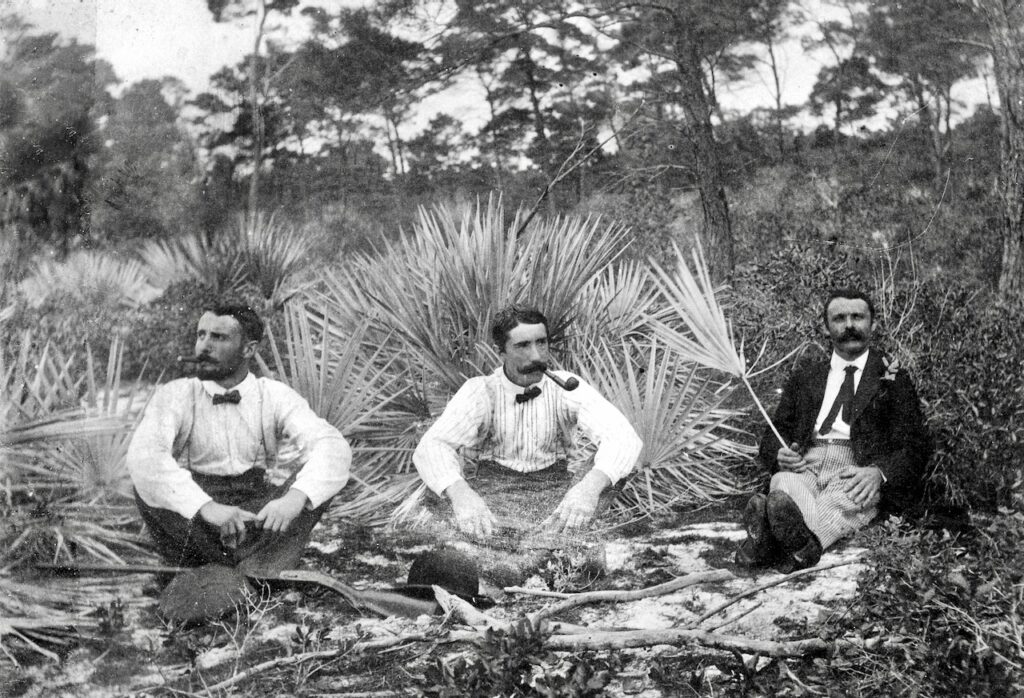Una giovane nella grande città
Angela, classe 1923, si sta avvicinando al traguardo dei cent’anni. La memoria, a quell’età, a volte vacilla un po’, come è normale. Non potrà mai dimenticare, però, quando nel 1939, appena sedicenne, fece le valigie e partì per Roma, assunta a servizio da una ricca famiglia. Per lei, giovane contadina che fino a quel momento non aveva mai visto altro che il piccolo paesino di Caleipo in cui era nata, il richiamo della capitale, la grande città, era sembrato un’occasione da non perdere, un sogno. D’altra parte, anche le ristrettezze economiche in una famiglia con cinque fratelli, orfani di padre, pesarono sulla scelta.
L’impatto con la realtà, tuttavia, si rivelò più simile a un incubo. «Il padrone – è la prima cosa che racconta, malvolentieri, se le si chiede di parlare di quell’esperienza – tentò di violentarmi. Io scoppiai a piangere e gli dissi che l’avrei riferito alla signora, sua moglie». A portarla nella “città eterna” era stato l’invito di una compaesana, presentatasi un giorno con la notizia che cercavano una “serva” a Roma.
Appena arrivata Angela si era già pentita della sua scelta: «Volevo tornare indietro, ma ormai era troppo tardi».
«Mia mamma non voleva che partissi, perché ero troppo giovane, ma a me sembrava una gran cosa e dissi subito di sì». Così, accompagnata dalla futura padrona, salita a Belluno, fece il tragitto in treno fino a quella che per un anno sarebbe stata la sua nuova casa. Un anno interno. Un’eternità, se si pensa che appena arrivata Angela si era già pentita della sua scelta: «Volevo tornare indietro, ma ormai era troppo tardi».
Con il passare dei giorni le cose non migliorarono. Oltre al comportamento inqualificabile del padrone, il cibo che le fornivano era scarso e la paga era bassa. «Mi davano sessanta lire al mese, mandando tutto direttamente a mia mamma, quindi a me non restava nulla, nemmeno il necessario per comprare un francobollo e spedire una lettera. Per fortuna, due volte ho trovato dieci lire in strada. La prima volta erano sotto un’auto. La seconda, le ho viste mentre andavo a fare la spesa. Il vento le trascinava via e io le rincorrevo», ricorda ridendo. «Con quei soldi sono andata a comprarmi un po’ di pane».
Dopo la disavventura romana, tutta un’altra storia furono i tre anni trascorsi tra Milano e Como. «A Milano, ero da una contessa in via Monte Napoleone, facevo la cameriera. La cuoca era una mia amica e poco distante, da un famoso avvocato, lavorava mia sorella. Lì mi sono trovata davvero bene. Guadagnavo centocinquanta lire al mese ed ero trattata con affetto. Ricordo che un giorno la cuoca era assente. Ho cucinato io e la signora mi ha fatto i complimenti: “Questa minestra è più buona di quella che fa la cuoca”, mi ha detto».
«I padroni erano amareggiati, perché si erano affezionati. Ma mia mamma era malata e dovevo tornare per assisterla. Mi è dispiaciuto andarmene, ma non potevo fare altrimenti».
Nel 1940 l’Italia entrò in guerra e il capoluogo lombardo iniziò a subire i bombardamenti alleati. Chi poteva, fuggiva. «La contessa aveva una villa a Como. Ci siamo trasferiti lì, in un posto bellissimo». Un po’ a malincuore, nel 1943 Angela dovette fare le valigie e rientrare a Belluno. «I padroni erano amareggiati, perché si erano affezionati. Ma mia mamma era malata e dovevo tornare per assisterla. Mi è dispiaciuto andarmene, ma non potevo fare altrimenti». Da Roma, intanto, i vecchi datori di lavoro avrebbero voluto riavere Angela con loro. «Hanno scritto chiedendomi di tornare. Gli ho risposto che non ci sarei andata per nulla al mondo».
L’esperienza di emigrazione si concluse così. Una volta a Belluno, dopo l’armistizio e l’occupazione tedesca, nel 1944 Angela si unì alla Resistenza come staffetta, nome di battaglia: Novella. «Mio fratello Gino era a capo di un gruppo di partigiani di stanza a Cirvoi. Per loro andavo fino a un deposito poco fuori Belluno a prendere prosciutti. Li mettevo in una borsa e li portavo a casa, riposti nel foro di una stufa a mattoni. Lui veniva a prenderli e mi consegnava le missive da recapitare a Quantin. Quelle le portavo nascoste negli scarponi». Non solo messaggi e rifornimenti. «Una volta Gino mi aveva portato un sacco pieno di bombe a mano da nascondere in soffitta. Mi aveva anche spiegato, nel caso ce ne fosse stato bisogno, come usarle», le torna in mente con un pizzico di allegria.

Un giorno, durante una rappresaglia nazista nella vicina Castion, sentì gli spari e il sibilo dei proiettili. «Sono corsa a recuperare le bombe per nasconderle. Se le avessero trovate, ci avrebbero incendiato la casa». Tutto finì con la Liberazione. «Un giorno felice. Con mia sorella abbiamo raggiunto una collina dalla quale potevamo osservare Belluno. Si vedevano i tedeschi sfilare in ritirata, con cavali e camionette. Uno spettacolo». A ostilità terminate si sposò, fece famiglia e rimase sempre nella “sua” Belluno.
Nel dopoguerra fu il fratello Giovanni a fare le valigie e a salpare verso l’Argentina, «dove ha vissuto sempre con una forte nostalgia, tanto che l’unica volta che è venuto in Italia per una vacanza, arrivato si è inginocchiato a baciare la terra», spiega Angela. Giovanni non tornò mai più al suo paese. Morì dall’altra parte dell’oceano. Ma questa è un’altra storia.