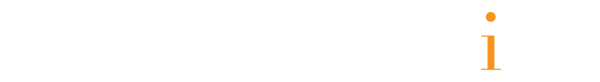Centodue anni dopo
di Aurimar Antonio Demenech – Vila Velha, Espírito Santo, Brasile
Ho sempre avuto un profondo interesse a scoprire le radici dei miei antenati della famiglia Demenech di Sananduva (Rio Grande do Sul).
La storia della famiglia inizia il 1° aprile 1842, con la nascita, a Sedico, del mio bisnonno, Francesco Antonio De Menech.
Francesco sposò Luigia Peloso, nata il 28 luglio 1838. Ebbero tre figli: Antônia (nata il 19 febbraio 1870), Annunziata Gioseffa (nata il 18 aprile 1872) e Luís Antonio (nato il 19 luglio 1877), mio nonno.
Lauro Antonio Demenech, figlio di Luís, e mia madre, Vidalvina Picolotto Demenech, continuarono la linea paterna della famiglia.
Del ramo materno della nostra famiglia, discendente delle famiglie Picolotto e Andreola, si hanno notizie più dettagliate.
La storia dei Demenech di Sananduva presentava invece delle lacune, perché i nostri bisnonni e nonni avevano lasciato pochi documenti, a eccezione di un passaporto italiano rilasciato durante il regno di Umberto I. Non ci sono registrazioni dettagliate di viaggi o eventi.
Come descritto nel passaporto italiano della famiglia De Menech, Francesco e i suoi famigliari emigrarono nel novembre 1891. Partirono da Sedico, in treno, fino al porto di Genova, dove si imbarcarono sul piroscafo “Duca di Galliera”. Si presume che viaggiassero in condizioni precarie, su una nave sovraffollata, in terza classe, senza assistenza medica e con un’alimentazione scarsa, dormendo sul pavimento. Arrivarono a Rio de Janeiro nel dicembre 1891 e rimasero in quarantena sull’Ilha das Flores, prima di dirigersi verso il Rio Grande do Sul.
La famiglia arrivò a Caxias do Sul alla fine di dicembre del 1891 e poi si trasferì a Nova Pádua. Non ci sono tracce delle attività familiari nel periodo tra il 1891 e il 1910. Nel 1910, Luís e sua madre, Luigia Peloso, arrivarono a Sananduva. Luís lavorò all’apertura di strade, acquisendo beni con i soldi guadagnati. Sposò Hermenegilda Salomoni Gasparini nel 1921, dalla quale ebbe quattro figli, tra cui mio padre, Lauro Demenech. Aprì una selleria nel centro della città.
Il mio interesse per le origini italiane della nostra famiglia è sempre stato grande, ma fino al 1988 avevo scoperto poco. Ha suscitato la mia curiosità una segnalazione sull’ottenimento della cittadinanza italiana per gli “oriundi”. Nostro padre parlava poco della sua infanzia e, anche quando gli veniva chiesto, non rispondeva. Mosso da questa segnalazione, ho cercato maggiori informazioni, consultando giornali ed esperti in materia. A quel tempo, vivendo già a Vila Velha, città natale di mia moglie, ho visitato il Vice Consolato italiano a Vitória, con i miei documenti personali e una copia del passaporto italiano dei miei bisnonni.
Ho seguito le istruzioni ricevute e ho iniziato a raccogliere la documentazione necessaria, come certificati di nascita, di morte, di matrimonio e atti parrocchiali. Dopo aver tradotto i documenti in italiano, ho richiesto la cittadinanza italiana presso il Consolato di Vitória, sulla base di una copia del passaporto di Francesco Antonio Demenech. Il 23 febbraio 1990 abbiamo ottenuto la cittadinanza italiana per tutti i componenti della famiglia di Lauro.
Nel 1993 ho inviato una lettera al Comune di Sedico, chiedendo informazioni su possibili parenti discendenti dalla nostra famiglia. Tre mesi dopo ho ricevuto risposta con i nomi e gli indirizzi dei discendenti del fratello del mio bisnonno Francesco. La risposta includeva un albero genealogico compilato a mano, riportante tutti i discendenti del padre del mio bisnonno, Giovanni Battista De Menech, e di suo fratello, Giovanni F. De Menech, che diedero origine ai rami dei De Menech che ora risiedono in Italia e in Svizzera.
È stato un grande incontro, sospeso nella memoria del tempo per centodue anni…
Nel 1993 esisteva un unico De Menech, discendente collaterale diretto, residente a Sedico. Dopo aver ricevuto l’informazione, gli ho scritto, condividendo la nostra storia e la documentazione ottenuta, sperando di scambiare maggiori informazioni. Lui ha inoltrato la mia lettera alla nipote, residente in un’altra provincia italiana. Nell’agosto del 1993, ho ricevuto una sua risposta, comprendente le fotografie di tutta la sua famiglia. Ha espresso sorpresa e interesse per la nostra storia condivisa.
La lettera riportava:
«Ho saputo, tramite mio zio, delle ricerche che stai facendo sulle generazioni della famiglia De Menech. Sono rimasta stupita dal fatto che parte di questa famiglia viva in Brasile, fatto di cui non ero a conoscenza. Il tuo interesse è anche il mio interesse, ma nelle mie mani non ho documentazione. Tuttavia, con la tua lettera, posso iniziare la mia ricerca».
Dalla risposta nella lettera inviata da Francesca, sembrava che ci conoscessimo da molto tempo, anche se né lei né io sapevamo dell’esistenza di questi personaggi delle famiglie De Menech dall’Italia e Demenech dal Brasile.
La nostra corrispondenza è stata tradotta manualmente, dato che abbiamo scritto in diverse lingue. Nel settembre 1993 ho viaggiato in Europa e ho visitato diversi paesi, tra cui l’Italia. A Sedico ho conosciuto il parente collaterale De Menech, in un incontro caloroso e gioioso. È interessante notare che era un falegname in pensione, proprio come mio padre. Nel 1994 venne a trovarci nell’Espírito Santo con due amici.
Poi sono andato in treno a trovare la famiglia della nipote che viveva in un’altra provincia e quando sono arrivato alla stazione, lei mi aspettava con suo marito.
Quando ci siamo incontrati, ci siamo abbracciati con grande gioia. Avevamo l’impressione che i fratelli perduti si fossero ritrovati. È stato un grande incontro, sospeso nella memoria del tempo per centodue anni…
Il 1993 è stato l’anno in cui mi sono ricongiunto con parte della mia famiglia Demenech rimasta in Italia. Fino ad allora, loro non avevano idea dell’esistenza del ramo Demenech di Sananduva, e nemmeno noi avevamo idea dell’esistenza del ramo De Menech di Sedico.
A casa, sono stato accolto dai suoi genitori e dal fratello. Sembrava che ci conoscessimo da una vita. Io parlavo poco l’italiano, in parte parlavo in dialetto veneto. Il padre di Francesca rideva ogni volta che pronunciavo una parola in dialetto, diceva che i suoi figli non lo conoscevano e che ormai in pochi lo parlavano ancora.
Da allora siamo rimasti in contatto tramite telefono e messaggi. Nel 2014 sono tornato a trovarli e ancora una volta sono stato accolto molto bene.
Attualmente il nostro albero genealogico fa risalire le informazioni del ramo della famiglia De Menech all’anno 1800.
Nel settembre del 1993, la gioia di aver trovato persone che condividono il mio sangue e la mia storia è stata un sentimento forte. Era come se un pezzo del puzzle della vita familiare dei Demenech finalmente andasse al suo posto. È stato un momento di grande appagamento e soddisfazione, perché ho imparato di più sul mio passato e su quello della mia famiglia. Voglio ricordare che anche i miei parenti italiani hanno provato queste stesse emozioni.
Il viaggio del 1993 ha riunito la famiglia Demenech, separata tra Brasile e Italia, collegandoci attraverso la nostra storia comune.